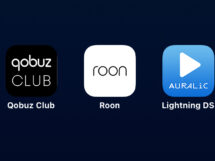Tom Waits. Un disco bellissimo che unisce jazz e blues in un sottile gioco di incastri sonori, dove l’essenzialità dell’arrangiamento si contrappone alla talvolta nevrotica pienezza dei testi, allusivi di un’agitazione dell’anima che fatica a prendere il volo.
Artista assai singolare Tom Waits, mai svendutosi al sistema che vuole che le etichette governino in modo fin troppo imbrigliato i propri artisti, si è sempre distinto per quella libertà di espressione che rasenta il furore. Le sue opere, a prescindere dal periodo preso in considerazione, sono sempre state caratterizzate dall’essere assolutamente libere – fin troppo talvolta – ma proprio per questo sono connotate da un vezzo artistico quanto mai multicolore, in grado di saltellare tra generi diversi in maniera quasi (in)naturale, un vero fuoco che arde nell’anima di questo artista sostenendolo in un impeto creativo a dire poco originale. Talmente originale da essere rimasto legato alla vita di tutti i giorni senza assurgere al grado di stella dello showbiz – si narra che per un periodo, tra un lavoro e l’altro, abbia fatto perfino il benzinaio – come a dire che per lui, la musica è davvero una passione, praticamente un hobby, qualcosa che si fa per il gusto di farla e non per obbligo, aspetto quest’ultimo che sovente porta ad opere insulse ed inutili, addirittura potenzialmente dannose nei confronti della carriera di un artista, quando ormai sopita la fiamma della creazione (mi si perdoni l’ardita citazione) si dà fondo al peggio di se come spesso è accaduto con altri artisti. Lui no, è sempre rimasto fedele a se stesso, scrivendo solo se era il caso, solo se quanto buttato giù fosse avvertito personalmente come efficace, creativo nel senso più nobile del termine.
Tom Waits. 1978, gli esordi

Siamo nel 1978, il primo periodo di Waits, quello molto vicino all’esordio, quel Closing Time caratterizzato da sonorità scarne ed essenziali, opera prima che vede la voce ancora acerba e meno connotata dalla cavernosità che in seguito sarebbe emersa, lavoro che è comunque già in grado di far percepire quel di più che poi verrà. Questa è l’opera che molti, me compreso, considerano la punta di diamante della produzione waitsiana, un lavoro che si pone al confine tra il primo ed il secondo periodo, immediatamente precedente alla pubblicazione del trittico Swordfishtrombones, Rain Dogs e Frank’s Wild Years, lavori che avrebbero costituito l’inizio del nuovo corso di questo artista.
La scaletta è piuttosto variegata, e ad un inizio morbidissimo e per certi versi inatteso da uno come lui – addirittura la dolcissima Somewhere tratta dal musical West Side Story di Leonard Bernstein, davvero tutta da sentire, maggiormente se si ha presente la versione originale – fa seguito una sequela di tracce irresistibili all’interno delle quali si sviluppa l’arte di Waits e dei suoi comprimari. A proposito di questi, va sottolineato come non siano affatto secondari ed anzi, in maniera che definirei pressoché perfetta, il loro contributo è essenziale nei confronti di questo originalissimo lavoro. Gli strumenti utilizzati sono pochi, in fin dei conti si tratta di un assetto jazzistico, quindi abbiamo pianoforte/organo, contrabbasso, chitarra, tromba, sassofono e batteria/percussioni a sostenere i pezzi del nostro. Ma si tratta di un signor sostegno, caratterizzato da incastri sonori perfetti dove il dettaglio la fa da padrone, un accompagnamento all’interno del quale si nota una ricchezza di rifinitura che pur nella sua semplicità ha del geniale, dove ogni singola nota è al suo posto, senza mai una slabbratura, una pur singola deriva che possa rovinare il risultato finale. La cadenza generale è indubbiamente molto bluesy, venata di jazz ma maggiormente orientata verso sonorità spesso sornione, altre volte più energiche ma mai sopra le righe, il classico sound da locale notturno insomma, quell’atmosfera fumosa ed alcolica tanto cara a questo artista, rintracciabile pressoché ovunque all’interno delle sue opere, quasi un marchio di fabbrica.

A livello timbrico la presa del suono è stata fatta davvero molto bene, in modo quasi insospettabile direi, sia per l’epoca sia per il genere, ove suoni sporchi e poco definiti potrebbero essere quasi d’obbligo nell’ambito di un genere per definizione introspettivo e quindi scarnificato della ridondanza tipica delle produzioni maggiormente commerciali. Ecco, se esiste un termine che possa validamente identificare perfettamente questo artista è “non commerciale”, da intendersi ovviamente nell’accezione massimamente positiva, ovvero completamente svincolato da quelle dinamiche che sovente identificano simili produzioni, dove il numero del venduto fa da spartiacque tra qualità e quantità, qui abbiamo solo qualità. Abbiamo quindi una bella scena sonora all’interno della quale sono disposti gli strumentisti, raccolta direi, come d’altronde si avrebbe in un piccolo e fumoso locale dove questi pezzi potrebbero essere suonati nella realtà. Sonorità sorprendentemente realistiche, veramente da sentire le pelli della batteria o le risonanze del pianoforte (riconoscibilmente verticale), oppure la veridicità del sassofono e della tromba. La voce dite? Roca, fumosa, profonda e morbida come solo Waits può fare; effettivamente mi sono spesso domandato come possa sostenere nel lungo periodo la sua performance, ma in tutta evidenza, questo è il connotato caratteristico, punto e basta, per lui funziona così.
 Tom Waits.
Tom Waits.
Tom Waits, i supporti
La ASYLUM RECORDS ne curò all’epoca l’edizione originale, CD o vinile sono le versioni oggi reperibili, di cui quest’ultima si presenta davvero ben fatta su vinile da 200 grammi ottimamente stampato, ma anche la versione digitale non è affatto male.
Come al solito, buon ascolto!
Diego Scardocci
Il vino, la proposta di doctorwine.
La voce inconfondibile di Tom Waits, scura, bassa, roca, unica per un cantante bianco, mi fa pensare proprio a quei vini bianchi che sono capaci di “cantare il blues”, che hanno caratteristiche quasi da vino rosso perché la fermentazione avviene con contatto fra il mosto e le bucce dell’uva. Qualcuno li chiama “orange wines” perché talvolta hanno un colore che vira verso tonalità aranciate. Tra tutti ho scelto uno dei migliori esempi di questa tipologia, il Kaplja 2015 di Damijan Podversic, un bravissimo viticoltore di Gorizia. Deriva da uve chardonnay 40% friulano 30% malvasia istriana 30% vinificati sulle bucce. Tre anni in botti grandi. Giallo dorato aranciato. Profilo olfattivo di grande impatto, con sentori di erbe aromatiche, the verde, fiori secchi, pietra focaia e cera d’api. Sapore caldo e molto salino, avvolgente, con accenni appena astringenti che derivano dal lungo contatto con le bucce. Costa in enoteca intorno ai 35 euro, se volete saperne di più scrivete a damijan@damijanpodversic.com
bianco, mi fa pensare proprio a quei vini bianchi che sono capaci di “cantare il blues”, che hanno caratteristiche quasi da vino rosso perché la fermentazione avviene con contatto fra il mosto e le bucce dell’uva. Qualcuno li chiama “orange wines” perché talvolta hanno un colore che vira verso tonalità aranciate. Tra tutti ho scelto uno dei migliori esempi di questa tipologia, il Kaplja 2015 di Damijan Podversic, un bravissimo viticoltore di Gorizia. Deriva da uve chardonnay 40% friulano 30% malvasia istriana 30% vinificati sulle bucce. Tre anni in botti grandi. Giallo dorato aranciato. Profilo olfattivo di grande impatto, con sentori di erbe aromatiche, the verde, fiori secchi, pietra focaia e cera d’api. Sapore caldo e molto salino, avvolgente, con accenni appena astringenti che derivano dal lungo contatto con le bucce. Costa in enoteca intorno ai 35 euro, se volete saperne di più scrivete a damijan@damijanpodversic.com
Buona degustazione!
Daniele Cernilli

© 2021, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.