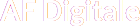Un diffusore audio è progettato per riprodurre il suono nel modo più fedele possibile rispetto alla sorgente originale e ogni suo componente gioca un ruolo fondamentale nella definizione delle caratteristiche sonore
Prende il via oggi I neofiti dell’Hi-Fi, una nuova rubrica dedicata a chi si sta avvicinando per la prima volta al mondo dell’hi-fi e non è ancora a proprio agio con termini tecnici, componenti, materiali e design dei prodotti votati all’alta fedeltà. Questi appuntamenti vogliono quindi puntare alla massima semplicità possibile e non vogliono scendere troppo nel tecnico o nello specifico, consci che a chi è alle prime armi con il mondo e il mercato Hi-Fi servono innanzitutto pochi concetti… ma buoni.
Come prima puntata abbiamo scelto il diffusore audio passivo (a quello attivo dedicheremo un approfondimento a parte), un dispositivo da collegare a un amplificatore progettato per riprodurre il suono nel modo più fedele possibile rispetto alla sorgente originale. Per ottenere questo risultato, ogni componente di un diffusore gioca un ruolo fondamentale nella definizione delle caratteristiche sonore.
Questione di “involucro”

Alla base della struttura di un diffusore troviamo il cabinet, ovvero il contenitore che ospita gli altoparlanti (o driver) e il crossover e che può essere delle dimensioni più disparate (dai diffusori da supporto/stand/scaffale fino a quelli più grandi da pavimento, detti anche “torri”). Il materiale con cui è costruito il cabinet influisce direttamente sulla qualità del suono, con il legno multistrato, l’MDF (un derivato del legno) e i materiali compositi che sono tra le scelte più diffuse per la loro capacità di minimizzare le risonanze indesiderate.
La rigidità del cabinet è essenziale per evitare vibrazioni che potrebbero alterare il suono, mentre alcune soluzioni adottano rinforzi interni o pannelli con forme specifiche per controllare meglio le onde stazionarie. Anche il peso del diffusore ha un impatto importante: un cabinet più massiccio aiuta infatti a ridurre vibrazioni parassite, migliorando la chiarezza e la precisione del suono. Alcuni produttori ricorrono anche a camere interne separate per isolare i driver e prevenire interferenze indesiderate tra le diverse gamme di frequenza.
Driver, frequenze… e un po’ di seta

Gli altoparlanti, o driver, all’interno di un diffusore sono i responsabili diretti della riproduzione delle frequenze sonore. Solitamente un diffusore audio utilizza una configurazione a due o tre vie, in cui ogni driver è dedicato alla riproduzione di una specifica gamma di frequenze.
- Il tweeter è il più piccolo tra questi e si occupa della riproduzione delle alte frequenze, solitamente comprese tra 2.000 Hz e 20.000 Hz. Grazie alle sue dimensioni ridotte e alla leggerezza della membrana, è in grado di muoversi rapidamente, restituendo suoni nitidi e dettagliati come le voci femminili, i piatti della batteria e gli effetti ambientali più raffinati. I tweeter possono essere realizzati con cupole in materiali come seta, alluminio o berillio, ognuno con caratteristiche sonore specifiche.
- Il midrange è responsabile delle frequenze medie, che vanno approssimativamente da 300 Hz a 3.000 Hz. È il componente che riproduce la maggior parte delle voci e degli strumenti musicali, garantendo una resa naturale e bilanciata. Di solito ha un diametro compreso tra 3 e 6 pollici ed è realizzato con materiali come carta trattata, polimeri o fibre composite per un suono più caldo e preciso.
- Il woofer è il trasduttore dedicato alle basse frequenze, tipicamente tra 20 Hz e 500 Hz. Il suo compito è riprodurre i suoni più profondi, come le note di un basso o il colpo di una grancassa. Essendo più grande rispetto agli altri componenti, può spostare una maggiore quantità d’aria, creando un suono potente e avvolgente. I woofer utilizzano membrane in materiali rigidi ma leggeri, come polipropilene, kevlar o fibra di carbonio.

Se un diffusore integra tutti questi driver, è un modello a tre vie, mentre se ne ha solo due (un tweeter e un woofer ad esempio) è a due vie. Esistono anche diffusori a “mezze misure” (2,5 o 3,5 vie) e a quattro vie, in cui un ulteriore driver si occupa della gamma ultrabassa migliorando la risposta dei bassi senza sovraccaricare il woofer principale.
Un’armonia necessaria
Un altro componente fondamentale in un diffusore è il filtro crossover (foto sotto). Il suo compito è di suddividere il segnale audio in diverse bande di frequenza, indirizzandole ai driver appropriati. Si tratta di un circuito che utilizza condensatori, induttori e resistenze per filtrare e distribuire il suono nel modo più accurato possibile. Detto molto semplicemente, i condensatori bloccano le basse frequenze e lasciano passare le alte e gli induttori fanno l’opposto, mentre le resistenze aiutano bilanciare i livelli sonori tra i driver.
Un crossover ben progettato riduce distorsioni e sovrapposizioni tra le diverse gamme di frequenze, assicurando una riproduzione equilibrata e naturale. Esistono crossover passivi, i più diffusi nei diffusori tradizionali, e crossover attivi, che necessitano invece di un’alimentazione esterna e sono tipici dei sistemi hi-fi più avanzati e degli diffusori amplificati.
Esistono inoltre quattro diversi ordini di un filtro crossover, sui quali non ci soffermiamo per non complicare eccessivamente le cose. Vi basti sapere che più alto è l’ordine del crossover, più preciso sarà il filtraggio, ma anche più complesso e costoso da realizzare. Nei diffusori di fascia alta si usano spesso crossover del secondo o quarto ordine, mentre in alcuni modelli più semplici si preferisce un primo ordine per una maggiore naturalezza della risposta in frequenza.

Mai sottovalutare il design
Il design di un diffusore non è soltanto una questione estetica, ma ha anche un impatto diretto sulla resa acustica. La forma del cabinet e la disposizione dei driver influenzano infatti la dispersione sonora e la gestione delle onde riflesse, con il risultato che alcuni diffusori adottano frontali inclinati per ottimizzare l’allineamento temporale dei driver, mentre altri utilizzano condotti reflex o camere accordate per migliorare la risposta dei bassi.
La scelta di un design con caricamento bass reflex o a sospensione pneumatica (cassa chiusa) può cambiare significativamente il carattere del suono, enfatizzando la profondità delle basse frequenze o privilegiando una riproduzione più controllata e definita.
Un diffusore bass reflex è dotato di un condotto o foro di accordo (solitamente sul retro del diffusore), chiamato porta reflex, che collega l’interno della cassa con l’esterno. Questo sistema sfrutta la risonanza generata dall’aria nel condotto per estendere la risposta alle basse frequenze senza richiedere un amplificatore più potente o un woofer più grande. Il risultato è un basso più profondo e presente, con maggiore efficienza rispetto a una sospensione pneumatica. Tuttavia, il bass reflex può introdurre una risposta meno controllata, con un basso più “rotondo” ma potenzialmente meno preciso. Inoltre, se il condotto non è progettato bene, può generare turbolenze e distorsioni.
Un diffusore a sospensione pneumatica ha invece una cassa completamente sigillata, senza aperture o condotti. Il volume d’aria interno agisce come un ammortizzatore per il movimento del woofer, garantendo un basso più controllato e preciso, con una risposta lineare e una migliore integrazione con le frequenze medie. Il principale svantaggio è una minore efficienza: per ottenere lo stesso livello di pressione sonora di un bass reflex, un diffusore a sospensione pneumatica necessita infatti di più potenza o di un woofer di dimensioni maggiori.

L’ascolto è fondamentale
I connettori e il cablaggio interno sono spesso sottovalutati, ma in realtà giocano un ruolo importante nella trasmissione del segnale. Terminali di alta qualità, placcati in oro o in materiali conduttivi di pregio, garantiscono una connessione stabile e riducono la perdita di segnale. Allo stesso modo, i cavi interni devono essere scelti con cura per minimizzare la resistenza e preservare la purezza del suono. Alcuni diffusori offrono la possibilità di bi-wiring o bi-amping, termini che possono confondere ma che in realtà sono semplici da comprendere.
Bi-wiring significa collegare un diffusore a un amplificatore usando due coppie di cavi invece di una. Il segnale per le basse e alte frequenze viene quindi separato prima di entrare nel diffusore, riducendo le interferenze tra i driver. Con il Bi-amping si va oltre; in questo tipo di collegamento, infatti, si utilizzano due amplificatori distinti, uno per le basse e uno per le alte frequenze, migliorando il controllo del suono e riducendo la distorsione. È un sistema più efficace del bi-wiring, ma richiede un investimento decisamente maggiore.

Tutti questi elementi, combinati tra loro, determinano le prestazioni finali di un diffusore Hi-Fi, influenzando dettagli come la spazialità, la precisione timbrica e la dinamica del suono. La scelta di un diffusore deve quindi tenere conto non solo delle specifiche tecniche, ma anche dell’ambiente di ascolto e delle preferenze personali, poiché ogni materiale e ogni soluzione progettuale contribuiscono a creare una firma sonora unica. Un ascolto attento in ambiente controllato resta quindi il metodo migliore per valutare quale diffusore sia più adatto alle proprie esigenze, dal momento che la sinergia tra componenti e spazio d’ascolto gioca un ruolo cruciale nella resa finale.
© 2025, MBEditore – TPFF srl. Riproduzione riservata.